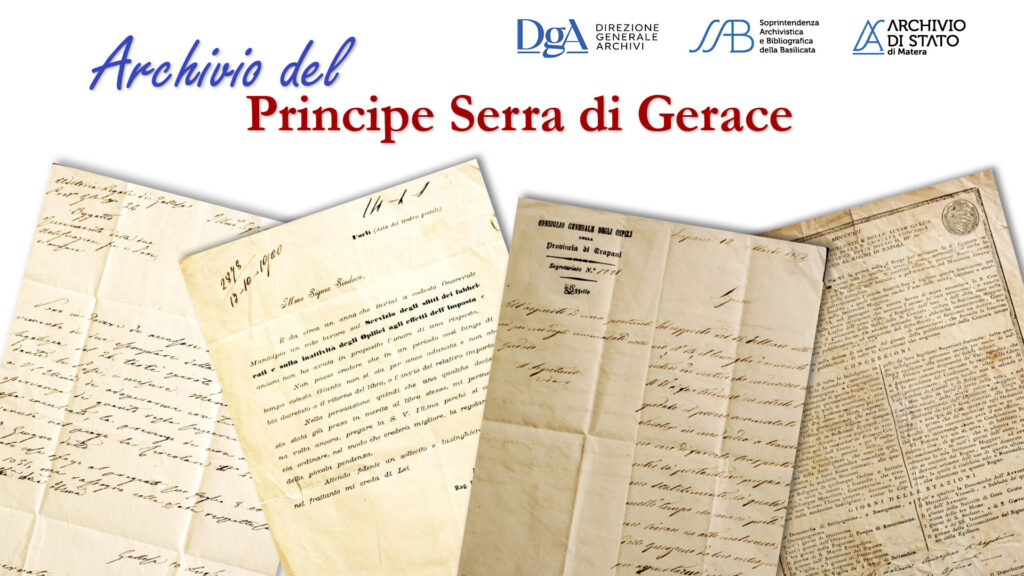Ci sono carte che, dopo aver attraversato secoli e vicende complesse, tornano a parlare.
È il caso della documentazione appartenuta alla nobile famiglia Serra di Gerace, finalmente riconsegnata alla comunità grazie alla disposizione del Tribunale di Matera, Sezione penale, del 27.11.2024.
Il fondo era giunto all’attenzione degli organi giudiziari nell’ambito di un sequestro eseguito dal Commissariato di Polizia di Policoro. Da allora, i documenti erano custoditi in deposito giudiziario presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, che ne ha garantito la conservazione curandone anche la prima descrizione tecnico-scientifica, realizzata dall’archivista di Stato Michele Durante, in attesa degli esiti giudiziari.
Le carte, numerose e di grande interesse, ricostruiscono le attività economiche, amministrative e sociali svolte nelle vaste proprietà agrarie dei Serra di Gerace tra la fine del XVII e la prima metà del XX secolo, nelle zone di Policoro e Montalbano Jonico. I Serra di Gerace furono una potente famiglia nobiliare di origine napoletana, titolari di ampie estensioni fondiarie nella Basilicata jonica a partire dalla fine del XVIII secolo.
Nel 1792, la principessa Serra-Gerace acquisì dal fisco borbonico il feudo di Policoro, già appartenuto alla Compagnia di Gesù. Da quel momento, la famiglia trasformò la zona in una tenuta modello, dotandola di infrastrutture produttive, colonie agricole, case rurali, allevamenti, impianti per la lavorazione della liquirizia e un palazzo padronale.
Per amministrare tali proprietà, i Serra si avvalevano di una rete di agenti e razionali che, con sede tra Montalbano e Policoro, curavano la contabilità, i contratti agrari e i rapporti con le popolazioni locali.
Ospiti illustri soggiornarono nelle residenze della famiglia, tra cui Giuseppe Bonaparte nel 1799 e re Ferdinando II di Borbone nel 1833. Per circa un secolo, i Serra di Gerace esercitarono una forte influenza economica e sociale sul territorio, fino alla dismissione delle proprietà avvenuta nel 1892 con la vendita del latifondo ai Berlingeri.
Oggi, grazie alla restituzione di questo fondo documentario, la storia di quella presenza aristocratica può essere nuovamente studiata e conosciuta, offrendo uno spaccato significativo sulle dinamiche agrarie e sociali del Mezzogiorno.
Tra i materiali spiccano i registri contabili, i bilanci agrari e gli elenchi della manodopera impiegata nelle tenute, insieme a documentazione relativa alla gestione zootecnica e alla lavorazione della liquirizia, attività particolarmente sviluppate nelle proprietà del principe. Completano il fondo numerose lettere manoscritte intercorse tra la famiglia e i propri fiduciari locali — agenti, razionali e amministratori — oltre a una significativa serie di atti notarili redatti da Carlo De Bona, attivo a Campomaggiore e in altri comuni del territorio lucano.
Si tratta di un fondo prezioso, in grado di documentare pratiche agrarie, assetti fondiari, modelli amministrativi e rapporti di lavoro in una regione chiave del Mezzogiorno moderno. Ogni documento restituito è un frammento di identità collettiva, che torna a raccontare il proprio tempo.
La consegna all’Archivio di Stato è un’occasione per ribadire il ruolo cruciale delle istituzioni e delle forze dell’ordine nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché nell’azione di contrasto al traffico illecito di opere e documenti antichi.
La documentazione è oggi conservata presso l’Archivio di Stato di Matera, dove potrà essere consultata, studiata e valorizzata nell’interesse della ricerca storica, della conoscenza e della cittadinanza.
Perché anche un archivio, dopo anni di silenzio, quando torna accessibile alla collettività, ricomincia a parlare.