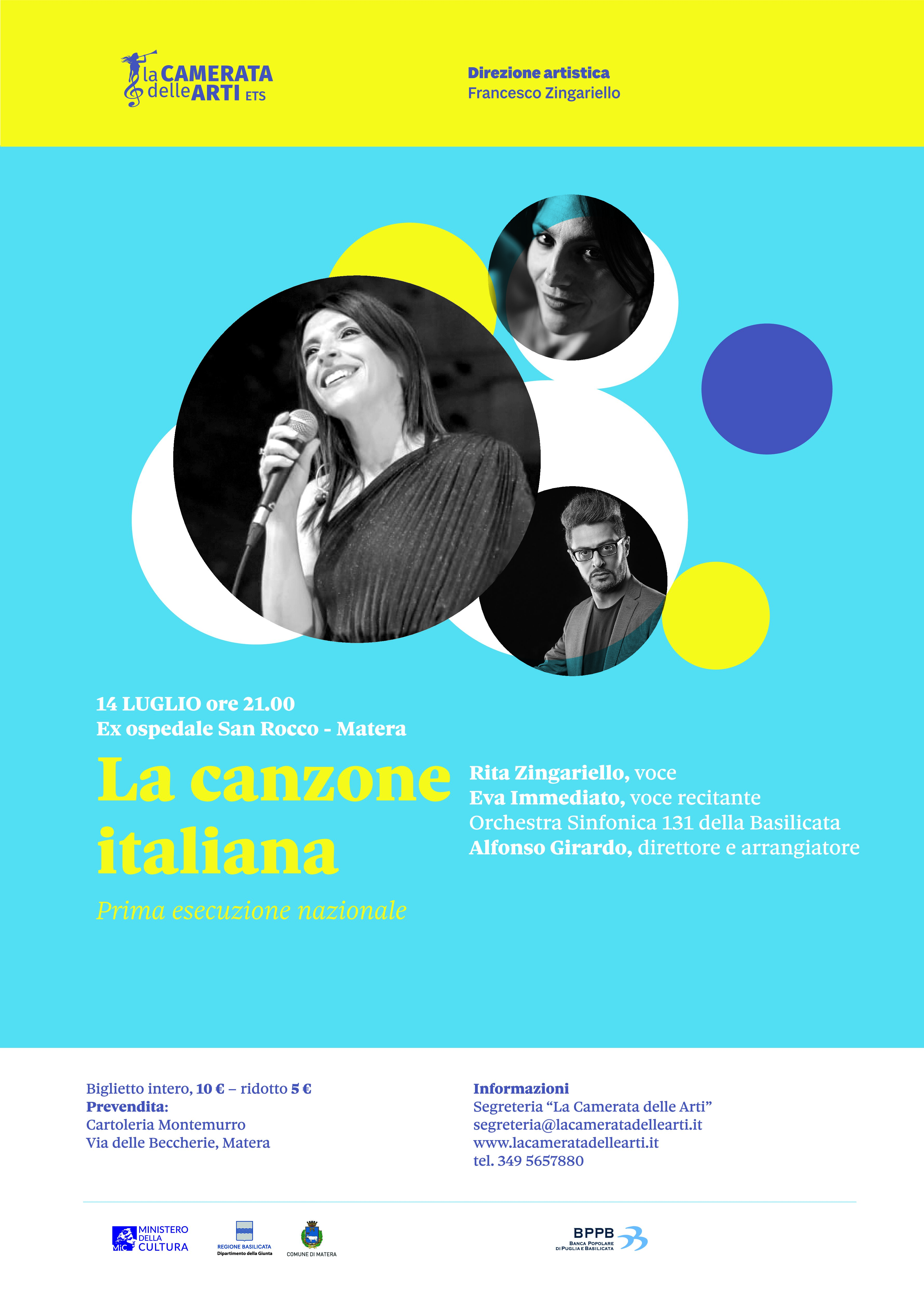Il direttore regionale della Protezione Civile di Basilicata, Donato Viggiano, attraverso una nota, porta a conoscenza il lavoro del Dipartimento da lui diretto, che analizza l’andamento pluviometrico della Basilicata nel primo semestre 2017, periodo di particolare crisi precipitativa e, di conseguenza, di disponibilità idrica.
"Il “regime” pluviometrico del semestre è stato confrontato – spiega Viggiano – attraverso la valutazione dell’anomalia di precipitazione e di indici climatici, con i regimi pluviometrici medi registrati a partire dal 1921. Per i dati storici sono stati utilizzati direttamente le elaborazioni riportate in letteratura, ed in particolare quelle presenti nel volume “Le precipitazioni in Basilicata 1921-1980” a cura di Caloiero et al CNR-IRPI Cosenza, in quanto le serie considerate sono state ritenute statisticamente affidabili. I dati pluviometrici del primo semestre 2017 sono quelli della rete idrometeopluviometrica gestita dal Centro Funzionale della Regione Basilicata, adesso in telemisura, ma nel secolo scorso in registrazione sin dal 1916. La scelta di considerare direttamente i valori medi storici del periodo 1921-1980, e non quelli del canonico trentennio idrologico di riferimento (1961-1990), è legata a due motivi: il primo è sicuramente correlato alla significatività delle elaborazioni sui valori medi presenti nella pubblicazione presa a riferimento, elaborazioni fatte a valle di una verifica di consistenza dei dati, recuperando parte degli stessi dalle storiche “strisciate” dei pluviografi registratori; il secondo, oltre alla dimensione consistente della serie storica, è legato al fatto che dal 1980 in poi, a causa del sisma che ha colpito la Basilicata prima, e dello smantellamento di fatto dei Servizi Tecnici Nazionali poi, si è assistito ad un costante impoverimento delle reti di monitoraggio pluviometrico, almeno fino al 2000, quando si è ripreso coscienza dell’importanza del dato puntuale e diffuso. La definizione dei quantitativi di precipitazione, soprattutto in periodi di conclamata carenza, ha implicazioni dirette sul tema delle risorse idriche, ma è anche collegabile ai processi di degradazione del suolo e alla loro suscettibilità verso fenomeni di desertificazione. Infatti, quando l'erosione si verifica in regime di forte deficit pluviometrico si parla di desertificazione che pone seri problemi di carattere economico-ambientale a causa dell'irreversibilità del processo". Lo studio prodotto dalla Protezione civile spiega inoltre che "la Basilicata ha un territorio prevalentemente montuoso-collinare con una parte residuale pianeggiante, circa l’8%, concentrata soprattutto a ridosso della costa ionica. I massicci montuosi più importanti: Pollino, Sirino, Monte Alpi, il Monte Raparo, Volturino costituiscono i maggiori rilievi dell'Appennino lucano. A nord-ovest della regione è presente un vulcano spento, il monte Vulture. I principali rilievi si dispongo lungo l’asse NO-SE che contrassegna l’Appennino. I principali corsi d’acqua della regione sono a carattere torrentizio: in particolare il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri, e il Sinni sfociano nel mar Ionio, il Noce nel Tirreno, l’Ofanto attraversa la Basilicata a nord. Numerosi sono i bacini artificiali, costruiti per usi potabili, irrigui ed industriali, presenti nella regione, alcuni con capacità di immagazzinamento notevoli: Basentello e San Giuliano sul Bradano, Camastra sul Basento, Pertusillo sull’Agri, Monte Cotugno sul Sinni, oltre a numerosi altri con invasi minori. Le coste lucane sono sabbiose sullo Ionio, rocciose e alte sul Tirreno. A livello litologico, il territorio della Basilicata è costituito prevalentemente da argille, componente che condiziona notevolmente la stabilità dei versanti collinari e montani. In ampie zone (Val d’Agri, Lagonegrese- Pollino) i carbonati, confinati da livelli impermeabili, danno vita ad importanti riserve idriche sotterranee, che sono, in parte, captate. In zona di Avanfossa, le formazioni sabbiose caratterizzano il paesaggio. Il clima è fortemente condizionato dalla morfologia ed è di tipo mediterraneo sulle coste e continentale sui rilievi montuosi, cambiando notevolmente da zona a zona: infatti una caratteristica è che la Basilicata è esposta a due mari. Le principali perturbazioni arrivano dalla parte tirrenica, e, a causa della presenza dei rilievi, scaricano le piogge più consistenti sulla parte occidentale della regione, dove, le precipitazioni medie annue raggiungono valori intorno ai 2000mm. In generale, il clima della regione è di tipo continentale (estati miti ed inverni rigidi), con caratteri mediterranei solo nelle aree costiere. I venti più frequenti provengono in prevalenza dai quadranti occidentali e meridionali"La prima analisi eseguita è stata il confronto asettico tra le mappe di pioggia dei due periodi considerati (media 1921-1980 e 2017). In particolare, partendo dai dati storici, è stata realizzata la carta delle isoiete riferita alla media delle precipitazioni cumulate registrate nel primo semestre del periodo 1921-1980 e la carta delle isoiete relativa al primo semestre del 2017. Dal confronto si evince che c’è una forte differenza tra i valori assoluti dei massimi e dei minimi di precipitazione nei due periodi, passando da quantitativi che hanno superato i 950mm di media nel primo semestre storico a quantitativi che superano di poco i 600mm per i massimi, e minimi che, nel 2017 hanno rasentato i 100mm. La rete idrometeopluviometrica della Basilicata. Un’informazione importante che scaturisce dall’analisi grafica è che la netta distinzione della distribuzione spaziale delle precipitazioni, che negli anni ha caratterizzato il regime pluviometrico della regione, separando con un’asse NO-SE le fasce pluviometriche (Bove et. Al. 2005), seguendo sostanzialmente la direzione dell’Appennino, non trova conferma nella distribuzione del primo semestre 2017, dove è ben evidente un’area centrale della regione caratterizzata da minori precipitazioni. Lo studio sembra confermare condizioni di deficit pluviometrico diffuse e maggiormente evidenti nelle aree interne della regione. Appare altresì chiara l’anomalia della distribuzione spaziale delle precipitazioni, con un andamento che negli anni ha caratterizzato il regime pluviometrico della regione, separando con un’asse NO-SE le fasce pluviometriche seguendo sostanzialmente la direzione dell’Appennino, mentre nella distribuzione del primo semestre 2017 evidenzia un’area centrale della regione caratterizzata da minori precipitazioni. Il deficit pluviometrico ha conseguenze sia immediate, poiché si traduce direttamente in deficit idrico, sia sul lungo termine, influendo in modo reale anche sulle riserve idriche superficiali e sotterranee. Considerando il periodo di riferimento con l’eventualità di avere un intero periodo estivo secco e duraturo, è presumibile che gli effetti negativi sulla gestione delle risorse idriche possano essere di non facile e rapida soluzione, andando a compromettere anche la ricarica dei bacini imbriferi più profondi. La corretta ed oculata gestione delle risorse, l’adozione di pratiche agricole, anche con l’individuazione cultivar meno esigenti dal punto di vista idrico, la riduzione degli sprechi domestici, la coscienza e la conoscenza di avere a disposizione un bene, l’acqua, non illimitato, devono necessariamente entrare a far parte della pianificazione di territori, per far fronte a periodi di criticità.