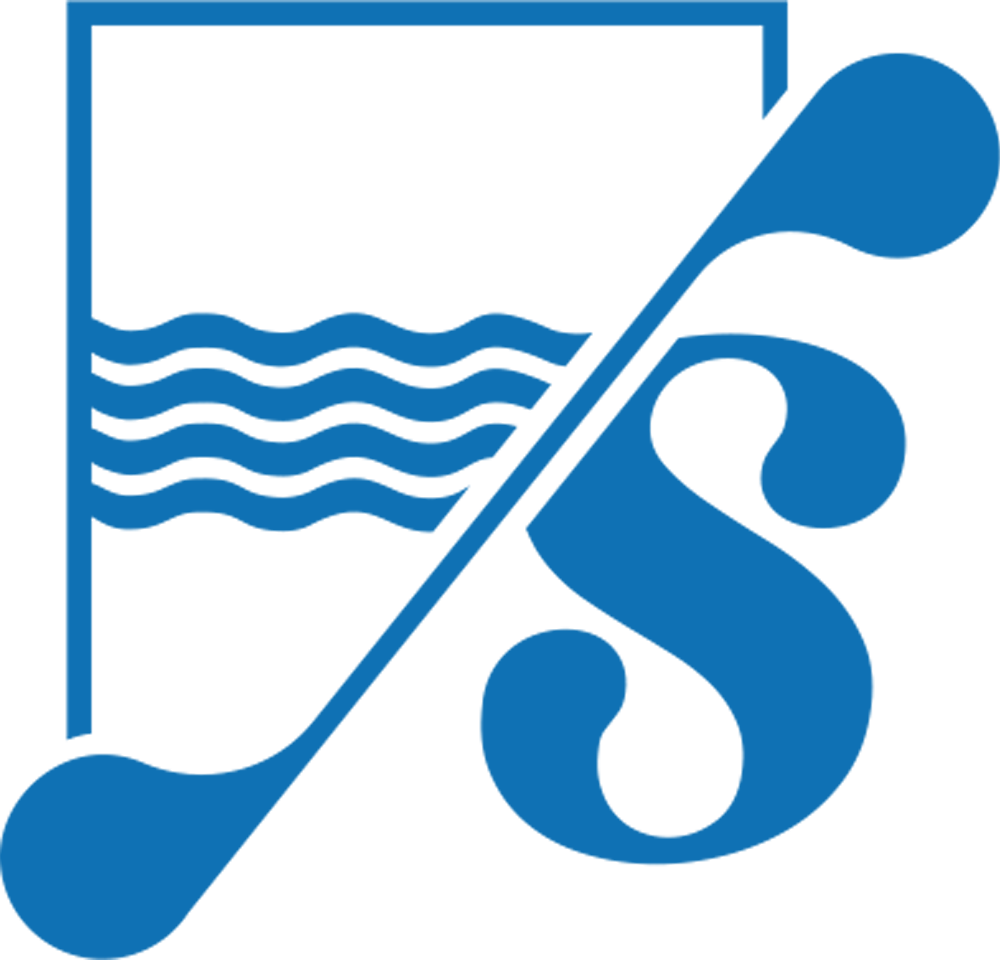INTERVENTO DEL PROF: GENNARO GIUSEPPE CURCIO,
Segretario generale – Istituto Internazionale Jacques Maritain – Roma
Stimatissimo Presidente,
Dopo 18 anni dal discorso pronunciato in occasione del 25° anniversario della fondazione dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain a Preganziol, su “Una politica per l’uomo”, oggi, a Matera, città simbolo della Cultura Europea, L’accogliamo in veste di Presidente della Repubblica Italiana, per inaugurare la prima Cattedra Maritain in Italia.
La ringrazio di cuore per questo dono straordinario e per la Sua manifestazione di stima e di affetto nei confronti del nostro Istituto. La ringrazia il Presidente Prof. Roberto Papini che per circa 40 anni ha introdotto intere generazioni al pensiero del filosofo francese, creando comunità, istituti, associazioni che, oggi, in streaming, seguono questo nostro evento da tutte le parti del mondo.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e creduto nella costruzione di questo progetto internazionale in maniera speciale: la Fondazione Mondo Unito di Città del Vaticano, attraverso il segretario di Stato, Sua eminenza il cardinale Pietro Parolin, la Regione Basilicata, la BCC Basilicata, la Fondazione Matera-Basilicata 2019.
La Cattedra Maritain Pace e dialogo tra le culture e le religioni del Mediterraneo, instituita tra l’Università degli Studi della Basilicata, grazie alla disponibilità della prof.ssa Aurelia Sole e all’impegno del prof. Maurizio Martirano e il Polo Internazionale delle Culture del Mediterraneo di San Chirico Raparo (PZ) nella persona del sindaco Claudio Borneo, vuole essere una base su cui poter costruire una riflessione profonda su un’Europa da ripensare umanamente, geograficamente e politicamente partendo dalla dignità dell’essere umano e dal rispetto dei diritti umani. Un’Europa, che possa aprirsi all’altro e che parafrasando Giorgio La Pira, possa costruire ponti e non muri, che trovi nella pace e nell’inclusione i pilastri della democrazia di cui è modello nel mondo.
La consapevolezza di “unità umana indissociabile” deve porsi a fondamento di quell’Europa democratica chiamata a svolgere un ruolo centrale nell’aiuto e nel supporto ai paesi sull’altra riva del Mar Mediterraneo.
La Basilicata, trovandosi al centro del Sud, e guardando alla storia passata, è stata sempre a contatto con tradizioni, culture, religioni differenti, madre accogliente di tanti popoli di diverse razze. Oggi vuole continuare ad essere terra di cambiamento e di speranza per le nuove generazioni, per i popoli che in questo momento storico vivono la guerra, la fame e l’emarginazione, per quelle diversità (di ogni tipo, disabilità, immigrazione, disoccupazione) che ancora non vengono accolte e rispettate secondo quei diritti di cui Maritain è stato padre. Ci sono giovani, Presidente, presenti anche qui, che a livello culturale, amministrativo, politico, religioso hanno voglia di dare un volto nuovo a questa Terra, alla nostra Italia e all’Europa, secondo quei valori professati e vissuti da Maritain.
Sappiamo quanto sia difficile convivere pacificamente, ma sappiamo che in passato la discussione sui diritti umani ha portato i suoi frutti. Il Maritain vuole impegnarsi, attraverso questo progetto della Cattedra, a dare il suo contributo culturale per preparare e costruire, con l’aiuto di tutti gli Stati del Mediterraneo, una Dichiarazione Universale di Pace che possa mettere insieme le diverse famiglie religiose e culturali su quei principi e valori umani riconosciuti da tutti e sottoporLa, poi, alla Sua attenzione.
Sviluppare un’azione che possa condurre ad una cultura di pace e non di terrore, significa ritornare a guardare il Mediterraneo come mare nostrum in cui si possano considerare l’Africa e gli Stati del Sud come fonti di ricchezze umane e risorse, e non più come territori di conquista, di sfruttamento e di povertà; tutto ciò comporta una trasformazione dell’agire economicopolitico. Guardare all’Europa, all’Africa, al mondo come insieme di persone e non solo come territori utili all’arricchimento, significa riscoprire quella “civiltà della persona” che rinvia ad una economia diversa, più umana e più solidale.
A settanta anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, è doveroso interrogarsi sui diritti – e gli impliciti doveri – in essa espressi e sulla loro validità ed attualità. Nel 1948 le difficoltà di comprensione e di intesa tra Paesi di culture e religioni diverse risiedevano più che sull’individuazione dei diritti quanto sul loro fondamento. Non si riuscì nemmeno ad accordarsi sull’idea che i diritti fossero espressione di una comune natura umana, ci si limitò solamente a prendere atto della “dignità” dell’uomo in quanto uomo. Il preambolo della Dichiarazione Universale riconosceva, infatti, una «dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana» e «diritti uguali ed inalienabili»; riconosceva, cioè, l’universalità di questi diritti nonostante le differenze delle culture. Riguardo all’individuazione dei diritti veniva accettato il pensiero del filosofo Maritain, espresso alla Seconda Conferenza Generale dell’Unesco a Città del Messico nel 1947, discorso di cui ricorderemo i 70 anni a ottobre nel palazzo di “Bellas Artes”, secondo cui si poteva convergere su alcuni “principi pratici comuni” .
Ciò che accade quotidianamente nel Mediterraneo non è umano. Non possiamo stare inermi, senza trovare soluzioni. Credere nella cultura della pace e dell’accoglienza attraverso la formazione e l’educazione può avvicinare le persone e farle viaggiare insieme, farle conoscere e farle confrontare senza timore.
L’Italia, essendo la Nazione più vicina a questi valori e con una storia di relazioni interculturali e interreligiose profonde con questi Stati del Sud, può davvero essere lo Stato controcorrente e capofila di un cambiamento radicale delle sorti europee; preferendo, coraggiosamente, alla materialistica logica economica, il valore e il rispetto della persona nella sua dignità. Scelte che, però, devono passare attraverso la politica e porsi come fautrici di bellezza e responsabilità nella vita di tutti noi, nell’incontro del volto dell’Altro. Scelte che, dobbiamo vivere, in primis noi, già a partire dalle nostre piccole comunità, per aiutare le società a credere nei valori veri e autentici. In questo anche la politica – nata sin dall’antichità per risolvere i problemi delle società, dei popoli e della gente – deve riordinare i suoi interessi mettendo la persona al centro. Certo è che le sorti dei cittadini del mondo non possono essere decise da logiche che prescindono decisamente dall’amore per l’Altro. In questa traslazione di prospettiva si dovrebbe cominciare a guardare ad una Europa che cominci dal Sud e guardi a Nord attraverso gli occhi e il vissuto delle persone.
La Pira nella Lettera a Paolo VI aveva compreso il vero problema dei nostri tempi: «Unificare il mondo, unificarlo facendo ovunque ponti ed abbattendo ovunque muri» . Nella costruzione del ponte dell’inclusione il calcolo strutturale non si serve di numeri per garantire l’efficienza e la sicurezza, ma di persone. Le persone sono quindi essenziali, spetta loro il compito di progettare, costruire, fruire e allo stesso tempo essere “pietre di edificazione”.
Presidente, nel discorso che Lei fece al 25° della Fondazione del nostro Istituto, diceva: “Quella di Maritain è una figura che merita di essere riscoperta e riproposta alle nuove generazioni anche perché la sua biografia di intellettuale rappresenta un punto di riferimento simbolico, che aiuta a capire la storia di questo secolo. C’è bisogno oggi, – e i giovani ne avvertono fortissima l’esigenza – di buoni maestri. E Maritain è, prima di tutto, un grande maestro”.
In questo senso, il filosofo francese, diviene una guida per molti giovani, che vedono in Lui la possibilità di un cambiamento che non parta dall’egoismo, dall’individualismo, dal nazionalismo o da un’economia di potere, ma dall’umiltà di saper vivere e voler vivere condividendo il cammino con gli altri, dal rispetto della dignità della persona, dai valori umani, spirituali e culturali che soli possono cambiare la mentalità delle nuove generazioni.
Maritain, in Tolleranza e Verità, mette in evidenza come il dialogo nell’amicizia possa condurre ad una crescita vera e dice
il termine fellowship vuole evocare l’idea di compagni di viaggio che per caso si ritrovano riuniti quaggiù e che camminano per le strade del mondo in buon accordo umano – per quanto fondamentali siano le loro opposizioni – di buon umore e in cordiale solidarietà, o, per dire meglio: in amicale e servizievole disaccordo. Ebbene, il problema del compagnonnage, della fellowschip, tra membri di differenti famiglie religiose, appare centrale per la nuova età di civiltà che si sta abbozzando nel crepuscolo nel quale siamo.
I popoli del Mediterraneo o Lago Tiberiade, come lo appellava La Pira, hanno bisogno di ritrovare questi tre punti come fondamenti di una crescita umana insieme: un “buon accordo umano”, una “cordiale solidarietà” e un “amicale e servizievole disaccordo” per potersi accogliere e vivere uniti, nonostante le differenti famiglie religiose, culturali e linguistiche. Non con la guerra e le armi, non con una diplomazia vuota, non con un dialogo apparente, ma nel rispetto della dignità e in un dialogo in cui ognuno rimane sé stesso nella sua identità ma che sa camminare con l’altro nel rispetto di quei diritti e di quei valori pratici che appartengono a tutte le culture: la pace, la solidarietà, l’amore, la giustizia.
A questi valori pratici, Maritain, richiama le nuove generazioni e le istituzioni nazionali per poter far comprendere la bellezza della vita e negare una cultura di morte e di terrore.
La partecipazione a questo Corso di Alti Studi sul Mediterraneo di tanti giovani italiani, europei e dalle varie coste del Mediterraneo è indicativa della volontà di attraversare insieme, con lo stesso sguardo pieno di speranza il ponte dell’inclusione, per trasformare le nostre società in una grande comunità umana fatta di persone, non in una dimensione utopica, ma in una dimensione storica, in cui ognuno saprà prendersi carico dell’altro nella libertà e nella responsabilità.
Solo questo nuovo modo di pensare, potrà aprire i nostri occhi, il nostro cuore e la nostra intelligenza ad un’azione capace di costruire vera “amicizia civile” per poter camminare insieme tra le onde agitate del nostro mare e portare quella “pace” e quel “ben vivere” frutto di solidarietà e responsabilità verso l’Altro.