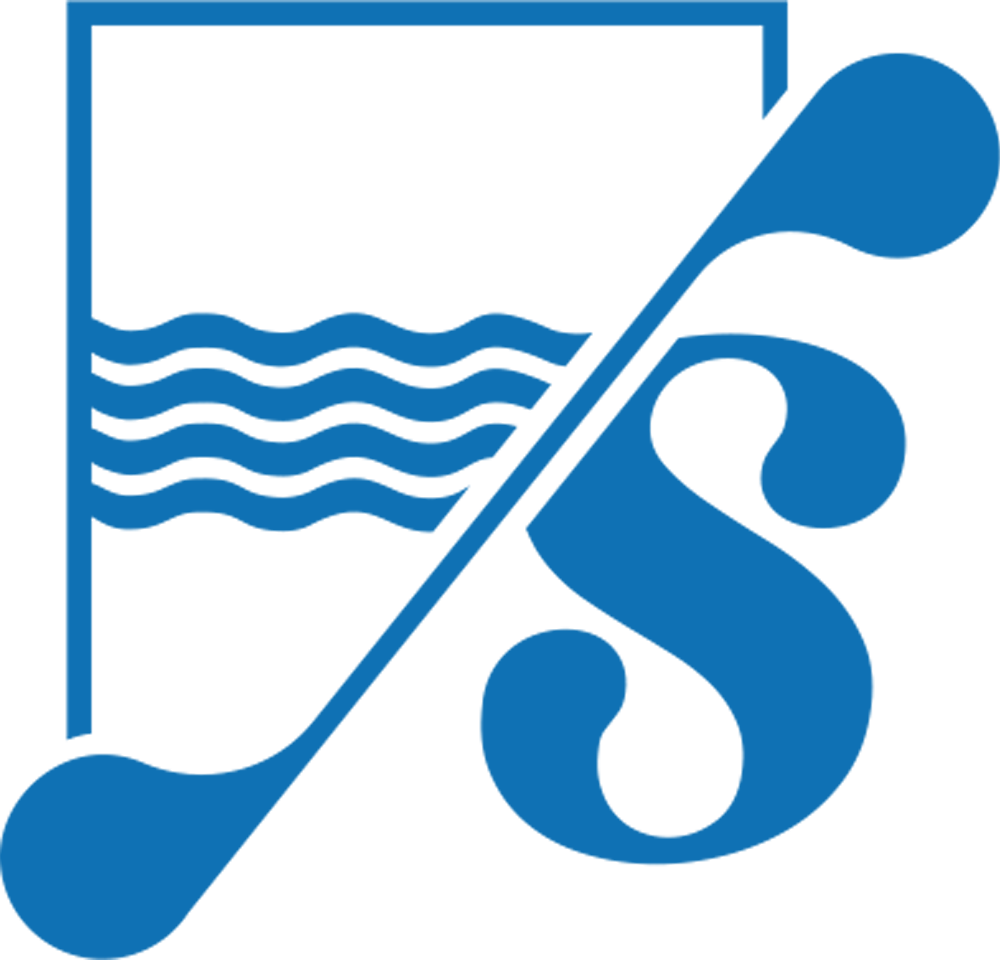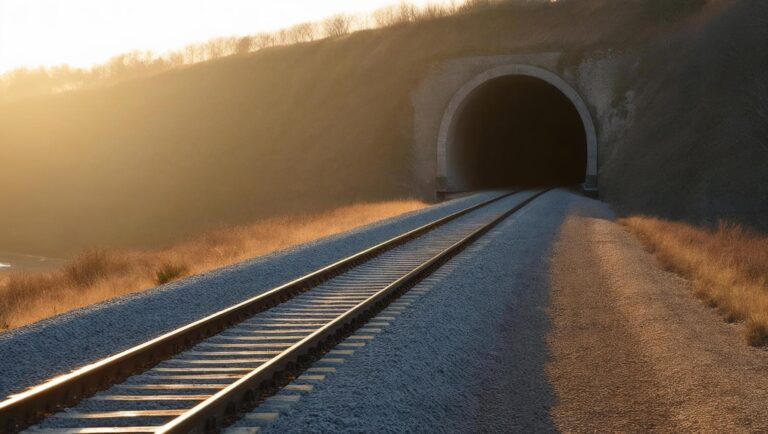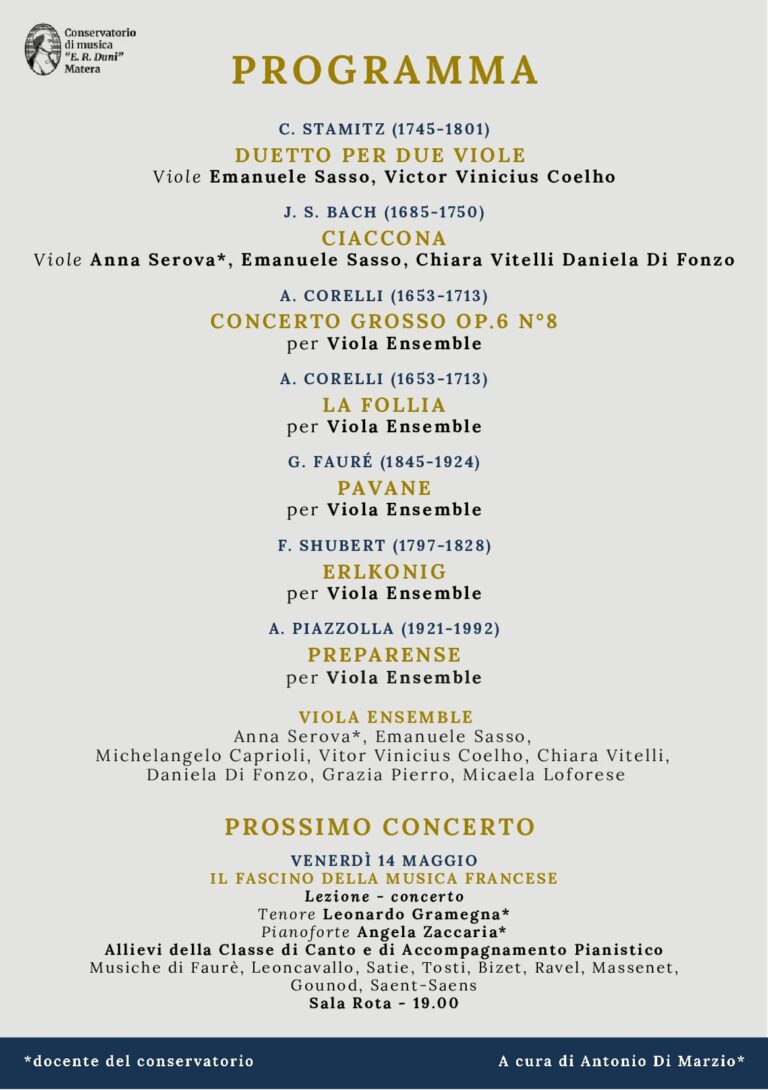Per il consigliere regionale dell’Udc “è stato un pensiero debole quello che ha ispirato il primo approccio con le multinazionali estrattive che non ha elevato a valore ciò che già era la Val d’Agri nel 1998”
“Nel confrontarci con l’Eni e con lo Stato dovremmo avere contezza di che cosa era la Val d’Agri nel 1998 e quali erano le sue prospettive di sviluppo prima dell’era delle attività estrattive petrolifere”. E’ quanto dichiarato dal capogruppo Udc, Vincenzo Ruggiero, nel corso della seduta consiliare dedicata al tema delle estrazioni petrolifere.
“Uno sviluppo concreto – ha continuato – e senz’altro alternativo rispetto a quello derivante dalle estrazioni petrolifere che avrebbe dovuto dare la consapevolezza di essere in possesso di un notevole valore aggiunto che non solo non andava e non va dimenticato, ma al contrario doveva e deve essere recuperato e preservato. E’ come se gli accordi precedenti fossero partiti dalla condizione di un’area desertificata e spopolata che aveva bisogno del 7 per cento delle royalties per individuare un percorso minimo di sviluppo economico. Un pensiero debole quello che ha ispirato un primo approccio con le multinazionali estrattive che non ha elevato a valore ciò che già era la Val d’Agri nel ’98, a prescindere dalle sue straordinarie risorse del sottosuolo: un’area di altissima qualità, di altissima levatura e con un piano di sviluppo già insito nella lettura del preesistente. Intanto, nel 1998, fu varato il Parco della Val d’Agri – Lagonegrese la cui struttura ha in pianta organica 64 addetti contro i 50 previsti dalle attività estrattive. Il territorio – è l’analisi di Ruggiero – vantava una superficie boscata, anche pregiata, di 42 mila ettari con un indice elevatissimo di boscosità del 35 per cento per territorio comunale che aveva generato la presenza di 80 imprese boschive e 15 falegnamerie che davano lavoro a circa 400 persone. Ancora, eravamo di fronte ad un’agricoltura fiorente ed irrigua coltivata per il 75 per cento ad ortofrutta e con il 20 per cento di giovani occupati di età tra i 14 e i 29 anni contro il solo 15 per cento del dato regionale, ma anche con punte d’eccellenza per la presenza di prodotti Ipg come il fagiolo di Sarconi ed i suoi 700 ettari di coltura tra Sarconi, Paterno e Grumento. Nella Val d’Agri fioriva anche una zootecnia di qualità che in circa 2.500 aziende allevava 40 mila ovi-caprini e 10 mila bovini in gran parte di razza podolica dalla quale derivava una produzione lattiero casearia di grande rispetto per la presenza di otto caseifici con prodotti d’eccellenza, quali il canestrato di Moliterno”.
“Un quadro economico e produttivo di tutto rispetto questo – ha approfondito Ruggiero – al quale non mancava nemmeno la cornice pregiata composta da tre piani paesistici di area vasta (Volturino, Sirino e Maratea/Rivello), centri storici di valenza architettonica (Brienza, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno e Corleto Perticara) affiancati da aree archeologiche (Grumento) ed aree religiose di chiara fama e dal forte richiamo (Madonna di Viggiano), ben tre stazioni sciistiche (Monte di Viggiano, Monte Volturino e Monte Sirino), tredici siti di interesse comunitario, i cosiddetti siti bioitaly, con riserve naturalistiche di grande pregio, quali la Abetina di Laurenzana e il Faggeto di Moliterno. Un territorio dal forte appeal ambientale, dunque, a beneficio di quel pensiero forte che avrebbe dovuto ispirarci e che deve animarci nel dialogo con le forze governative nazionali e le aziende estrattici. Si potrebbe, così, anche propendere verso uno sviluppo sostenibile che faccia riferimento al turismo naturalistico, così come è avvenuto nel Parco Nazionale d’Abruzzo che fa registrare circa 2.000.000 di presenze con una ricaduta economica di circa 300 milioni di euro ed una occupazionale di 1.500 unità. Il rischio, invece, è che noi potremmo ritrovarci con il Parco della Val d’Agri da zona di grande pregio ad area rapinata, depredata, sfruttata e poi abbandonata. In questa missione avremmo il conforto dell’esempio del Vallo di Diano, sede del Parco del Cilento, dove una mobilitazione popolare sostenuta e dalle istituzioni e dalla cultura attraverso una relazione del prof. Ortolani, docente di geologia dell’Università di Napoli, che rimarcò la fragilità sismica ed idrogeologica del territorio sconsigliandone le perforazioni, impedì l’inaugurazione dell’era dell’oro nero. Al contrario, nel confine lucano, a Brienza le perforazioni sono state permesse con la formazione di pozzi esauriti che si sono trasformati in discariche abusive con il risultato che gli indicatori occupazionali ed ambientali del Vallo di Diano sono altamente positivi mentre quelli dell’area lucana interessata dalle trivellazioni parlano di area di degrado, emigrazione e spopolamento”.
“Una riflessione sul ripristino ambientale dei pozzi esausti – ha aggiunto Ruggiero – ci spingerebbe, poi, a far presentare dei piani di ripristino ambientali corredati di fidejussione viste le esperienze delle perforazioni avvenute in Val Basento da parte dell’Eni dove non vi è stato alcun ripristino ambientale e le aree dei pozzi esausti sono diventate ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Pertanto, è necessario affrontare le multinazionali con il pensiero forte di chi difende un territorio che è stato tributario nel passato di risorse umane e naturali (acqua). La scommessa è tutta qui: far convivere il diavolo e l’acqua santa, il petrolio con il parco. Solo così – ha concluso Ruggiero – e nel pieno rispetto della sacralità del nostro territorio, si potrebbe e si dovrebbe stare dalla parte del popolo lucano che dà tanto e merita altrettanto e la cui generosità andrebbe premiata secondo principi di equità, rispetto e giustizia” .