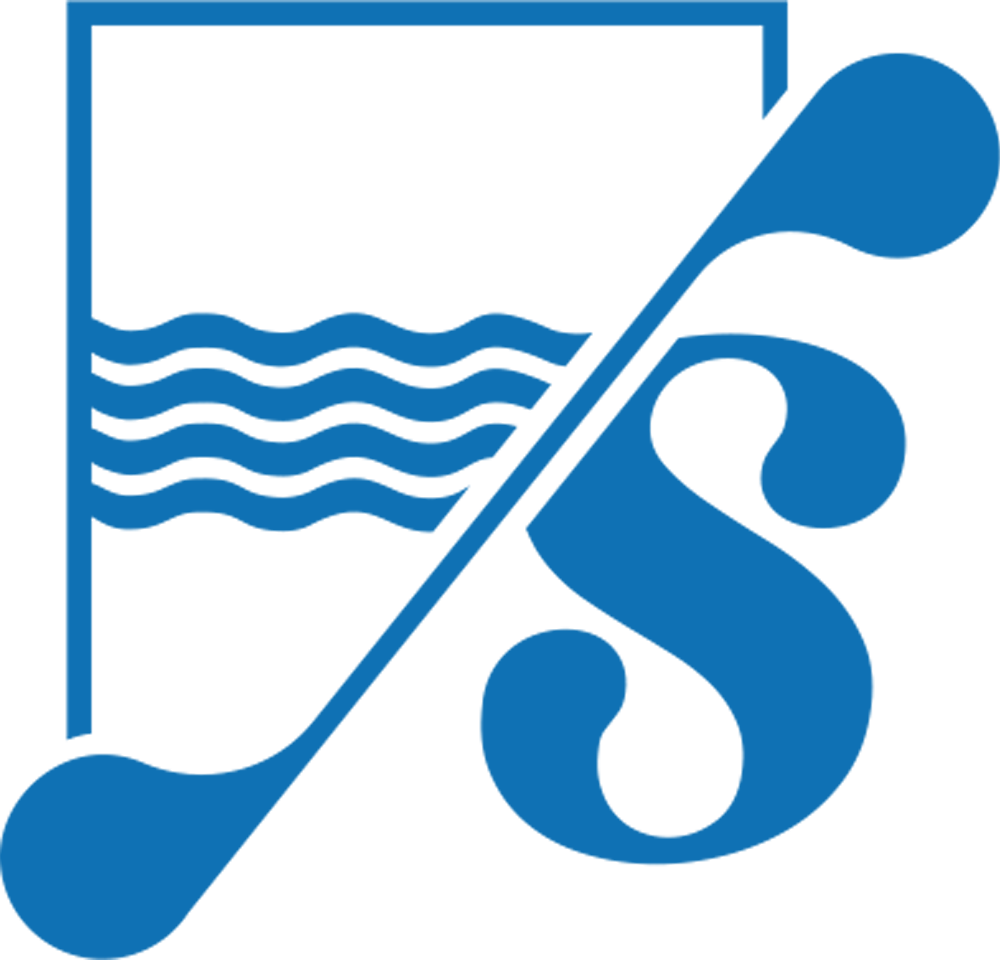“Aver cura del futuro anche nella dimensione storiografica di un proficuo rapporto intergenerazionale nella programmazione ed attuazione dei percorsi di ricerca e conseguenti iniziative sulle risultanze scientifiche, così come nell’impostazione e realizzazione di questo Convegno, nell’ambito di una Giornata della Storia, alla quale si pensava da tempo e qui ora positivamente concretizzatasi, con prospettiva di future annuali edizioni, configurabili quali proficui ed ampi cantieri di ricerca che da Sud sviluppino sempre più intensamente raccordi e confronti scientifici d’ambito nazionale ed internazionale”.
E’ quanto ha, tra l’altro, evidenziato il presidente della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, Luigi Mascilli Migliorini, nell’ambito delle considerazioni conclusive dell’interessante convegno di studio “Aver cura del futuro tra processi storici e ‘tessuti’ della memoria”, svoltosi il 28 maggio scorso a Potenza, nell’Aula Magna dell’Università degli studi della Basilicata.
Il convegno, promosso nell’ambito della XII Settimana Internazionale della Ricerca – Giornata della Storia, cui è stata conferita specifica medaglia di rappresentanza dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato organizzato dall’Università degli studi della Basilicata – Dipartimento di Scienze Umane e dalla Deputazione Lucana di Storia Patria – Istituto per gli Studi Storici dall’antichità all’età contemporanea, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Potenza, l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e la Società Italiana per la Storia dell’Età moderna.
Un convegno le cui connotazioni e finalità d’ordine scientifico sono state richiamate, in apertura dei lavori, dal responsabile scientifico, Antonio Lerra (Unibas, Presidente Deputazione Lucana di Storia Patria), che, anche portando i saluti della Rettrice, Aurelia Sole, ha richiamato precedenti cantieri di ricerca ed iniziative riconducibili al rapporto, al centro del Convegno, tra Storia, Memoria e relative tipologie e modalità di percezioni e rappresentazioni nel tempo. Al riguardo evidenziando, tra l’altro, come Storia e Memoria, seppur riconducibili a dimensioni distinte e con proprie specificità, presentino anche “terreni comuni” da dover, però, accuratamente analizzare e rappresentare in rapporto soprattutto ad aspetti, momenti e protagonisti della complessiva processualità storica di donne e di uomini, dall’antichità all’età contemporanea.
Ai successivi saluti istituzionali di Paolo Augusto Masullo, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, di Debora Infante, Dirigente-Ufficio Scolastico Regionale-Basilicata, di Vito Santarsiero, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata e di Patrizia Minardi, Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione Internazionale – Regione Basilicata, hanno fatto seguito due sessioni di lavoro, rispettivamente presiedute da Aurelio Musi e Luigi Mascilli Migliorini.
Sono state affrontate varie tematiche e problematiche, metodologiche e di merito, di rilevante interesse, dall’antichità all’età contemporanea, a partire dal rapporto tra Unità d’Italia e “questione” brigantaggio tra Storia, memoria e rappresentazioni, oggetto della relazione introduttiva del prof. Lerra, cui hanno fatto seguito numerosi altri interventi sia di docenti e ricercatori dell’Unibas (Ariel Lewin, Stefania Gallotta, Alessandro Di Muro, Donato Verrastro, Antonio D’Andria, Alessandro Albano) che di altre Università e Istituti di ricerca (Salvatore Lardino, Giuseppe Caridi, Valeria Verrastro, Salvatore Barbagallo, Giovanni Brancaccio, Francesco Mineccia, Marco Trotta).
Tra i numerosi temi e problematiche affrontati nel corso dell’intensa giornata, peraltro caratterizzata da ampia discussione, particolarmente dibattuto quello relativo alle Storie regionali.
Al riguardo, nel corso del suo intervento, Giovanni Brancaccio (Università di Chieti-Pescara) ha molto insistito sulla necessità di riconsiderare le Storie regionali alla luce dei più generali quadri nazionali ed europei, così da sgombrare il campo, ha evidenziato, da ricostruzioni spesso poco attente agli effettivi contesti politico-istituzionali e socio-economici di riferimento. E ciò anche per una realtà, quale quella degli Abruzzi, per molto tempo percepita e rappresentata, lungo il ciclo della modernità, esclusivamente sotto il profilo agro-pastorale, non cogliendone, così, elementi di indubbio dinamismo che ne hanno contraddistinto il ben più complesso profilo storico, dall’antichità all’età contemporanea, sia sul piano economico che su quello socio-professionale.
Un campo di ricerca, questo delle Storie regionali, su cui si è, tra l’altro, ampiamente soffermato anche Aurelio Musi (Università di Salerno), evidenziando come siano già da alcuni anni in corso specifici lavori che, muovendo dalle più recenti linee guida stilate dall’UNESCO per la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale delle regioni italiane, hanno come obiettivo portante una più generale e sistemica ricostruzione dei profili storici anche delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia.
Sul ruolo baricentrico esercitato, nello spazio Euro-mediterraneo, dal Mezzogiorno d’Italia, si è soffermato Giuseppe Caridi (Università di Messina) che, ricostruendo aspetti e momenti particolarmente significativi del periodo riconducibile alla Corona d’Aragona, ne ha evidenziato sia il complesso ed articolato sistema politico-istituzionale, sia anche il fervore artistico e culturale caratterizzante la corte di Napoli, tra Medioevo ed Età moderna.
Relativamente alle peculiarità delle città del Mezzogiorno d’Italia in età longobarda ed alle loro successive rappresentazioni si è focalizzato l’intervento del prof. Alessandro Di Muro (Università della Basilicata), mentre, sull’età classica in generale e, più in particolare, sull’attualità di alcuni elementi caratterizzanti il modello politico-istituzionale d’età romana si è soffermato il prof. Ariel Lewin (Università della Basilicata). Rispetto all’analisi critica degli scritti di alcuni rilevanti storici greci è, inoltre, intervenuta la prof.ssa Stefania Gallotta (Università della Basilicata) che ha, tra l’altro, evidenziato come anche i “silenzi” su alcuni eventi particolarmente significativi della storia antica possano essere oggi rivelatori di peculiari punti di vista e, dunque, da analizzare tenendo sempre presenti i più generali contesti di riferimento.
In rapporto all’uso dell’antico in età moderna, Antonio D’Andria (Università della Basilicata) ha, tra l’altro, evidenziato il largo utilizzo, anche politico, di immagini e rappresentazioni riconducibili alla cultura classica, delineando un complessivo quadro di storie locali nelle quali obiettivi di autolegittimazione di ceti e gruppi dirigenti erano alla base delle stesse “commissioni” ad eruditi. Di qui il largo utilizzo anche di santi e patroni quali fondatori di città e centri abitati.
In altra prospettiva il richiamo all’Età napoleonica, tra l’altro caratterizzato da viva attenzione alle traduzioni di testi costituzionali, così come emerso da specifici riferimenti di Alessandro Albano (Università della Basilicata) al peculiare “Catechismo costituzionale della monarchia spagnola”.
Sulle prospettive degli studi sui processi economici si è soffermato Salvatore Lardino (Deputazione Lucana di Storia Patria), ponendo in insistito risalto l’importanza dell’interdisciplinarietà oltre che dell’attenzione ai contesti di riferimento. Una problematica, questa, linearmente emersa anche dall’intervento del prof. Donato Verrastro (Università della Basilicata), in rapporto all’attenzione riformatrice conseguente alla Legge Zanardelli per la Basilicata. Un tema, questo delle politiche riformatrici di inizio Novecento, ripreso dal prof. Antonio Lerra, tra l’altro, in rapporto agli indirizzi progettuali nittiani ed alle relative pratiche attuative sui territori.
Un convegno, dunque, di alto profilo scientifico, oltre che ricco di tematiche e problematiche trattate e messe a fuoco, che vanno ad allargare ed a portare ad ulteriori sviluppi – ha sottolineato a conclusione dei lavori Lerra – il già ampio cantiere di ricerca in atto, nel quadro, peraltro, di un virtuoso esempio di raccordo interistituzionale, in una lungimirante visione di “cura per il futuro”, oltre che sul piano storico e storiografico, nel positivo operare congiunto di più generazioni di ricercatori e studiosi.