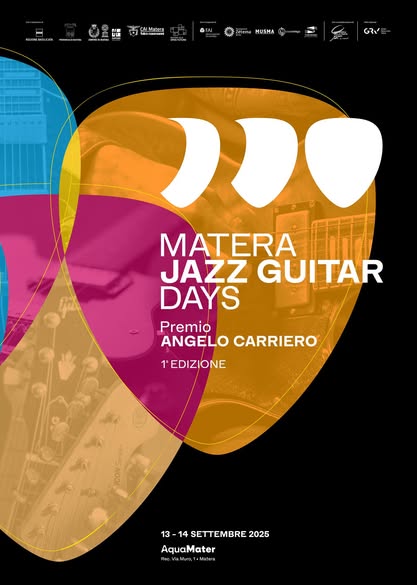Oggi, nel corso di un seminario congiunto, tenuto presso il Cern di Ginevra, delle due grandi collaborazioni Cms ed Atlas (i cui due apparati sperimentali hanno il compito, tra gli altri, di cercare il bosone di Higgs, responsabile della massa di tutte le particelle elementari che costituiscono la materia conosciuta e quella ancora da esplorare), sono stati mostrati i risultati delle recenti analisi compiute alla ricerca del bosone di Higgs, la particella proposta nel 1964 da Peter Higgs per spiegare perché tutte le particelle che conosciamo hanno una massa, e tra loro differente.
L’ultimo tassello che mancava al Modello Standard, la teoria che descrive tutte le particelle elementari di cui è costituito l’universo e le interazioni che fra di loro avvengono, era proprio questa sfuggente particella, della quale ben poco si conosceva.
Nell’Auditorium del Cern di Ginevra , dopo la raccolta dei dati sperimentali del 2011 e della primavera 2012, che hanno consentito di raddoppiare l’enorme quantità di dati sperimentali a disposizione, la leggera anomalia mostrata nello scorso dicembre 2011 (che rappresentava un’indicazione della presenza di una nuova particella ma non la certezza di averla effettivamente “osservata”) è divenuta ciò che in Fisica chiamano una “strong evidence”.
Entrambe gli esperimenti mostrano una chiara evidenza di una nuova particella con massa tra 125 e 126 GeV che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche del bosone di Higgs. Per averne la certezza assoluta, e parlare di “discovery” occorrerà aspettare ancora qualche mese. Ma ora si sa che questa particella, appartenente alla famiglia dei bosoni, esiste e sappiamo dove cercarla.
A queste ricerche, importantissime per raggiungere la comprensione della materia di cui è fatto l’universo e per rispondere ai principali dubbi che ancora abbiamo sulla sua reale costituzione e consistenza, partecipano anche ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata. Oltre a Nicola Cavallo, Ordinario di Fisica Sperimentale del Dipartimento di Chimica, e componente della collaborazione scientifica Cms (“Compact Muon Solenoid”) anche Francesco Fabozzi, ricercatore di Fisica Sperimentale presso la Facoltà di Scienze. Entrambi – si legge in un comunicato – fanno parte del gruppo napoletano che circa dieci anni fa ha iniziato la progettazione e la realizzazione di una parte dell’apparato sperimentale Cms. Lo stesso gruppo, oggi, oltre a contribuire al funzionamento dell’esperimento, partecipa attivamente all’analisi dei copiosi dati sperimentali raccolti tra il 2011 ed il 2012.
L’esperimento Cms è uno dei quattro esperimenti installati sulla macchina acceleratrice Lhc (“Large Hadron Collider”, il grande acceleratore e collisore di protoni) del Cern (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, storicamente Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra, localizzato sul confine franco-svizzero.
Cms, assieme all’apparato Atlas suo antagonista, è stato progettato e costruito negli ultimi vent’anni, per osservare i risultati delle collisioni tra fasci di protoni che avvengono nell’acceleratore LHC. In tali collisioni l’energia viene trasformata in materia, sotto forma di centinaia o anche migliaia di particelle, e compito del rivelatore Cms è quello di osservare, misurare e registrare tutte le particelle prodotte per ricostruire preziose informazioni sulle interazioni fondamentali che ne regolano il comportamento e che, in buona approssimazione, ripropongono le condizioni presenti dei primi istanti di vita dell’Universo.
Per fare ciò è stato necessario progettare e costruire un rivelatore molto complesso, alto come un edificio di sei piani, lungo una quindicina di metri e del peso di circa 14,000 tonnellate. La sua realizzazione ha coinvolto una collaborazione internazionale di più di 2000 ricercatori (fisici, ingegneri, tecnologi) provenienti da oltre 170 istituzioni di ricerca (Università e laboratori) di 40 Paesi.
BAS 05