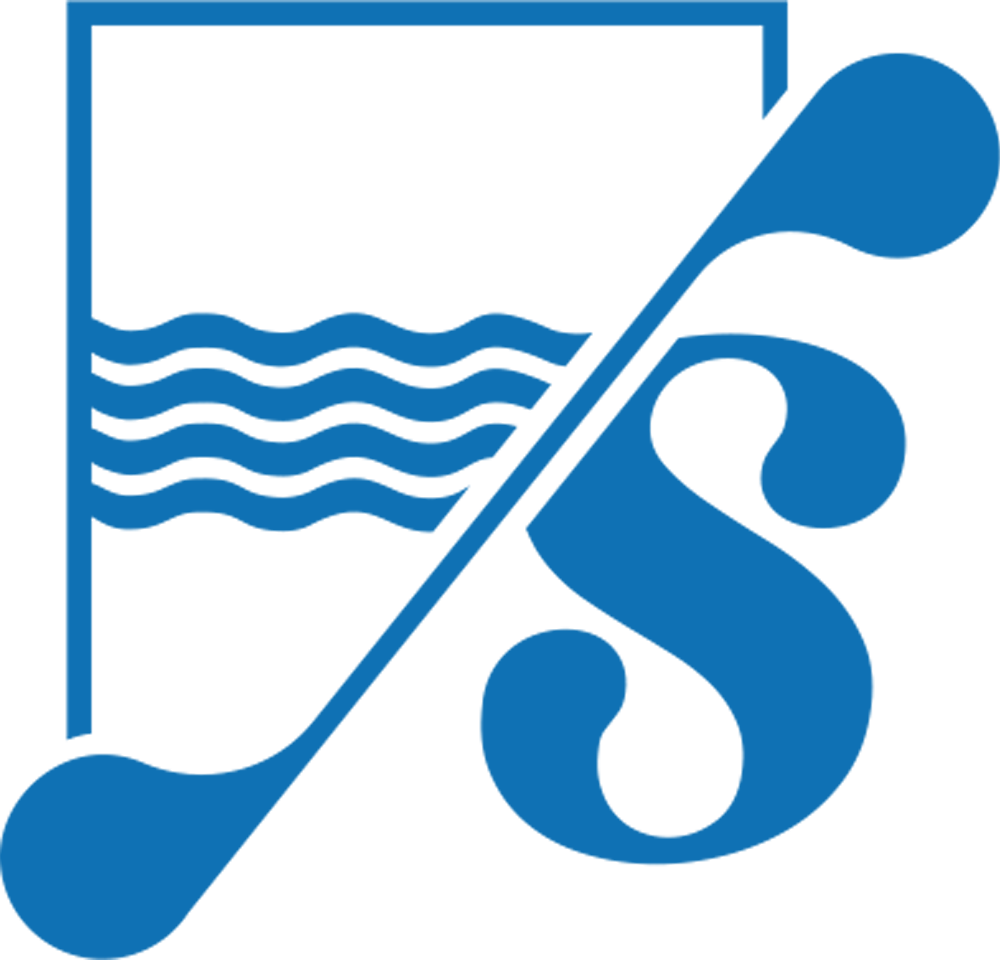Il territorio “agrario” e cioè quello che rimane ad oggi ancora allo stato “naturale” o semi-naturale costituisce anche gran parte del patrimonio paesaggistico nazionale e denota una forte identità italiana fatta di usi, costumi, tradizioni, culture del paesaggio italiano. Questo territorio convive con una delle maggiori risorse nazionali che è il turismo: agricoltura di qualità e turismo culturale, non standardizzato o di massa, costituiscono un potenziale enorme per il nostro Paese se concepite in una logica di sistema.
Sono questi i temi del Convegno, organizzato da CONAF in collaborazione con Italia Nostra, dal titolo “verso una nuova agricoltura, sintesi di culture identitarie e turismo: per una economia etica del territorio e per la tutela del paesaggio”, che si +è svolto per due giorni a Matera.
Al dibattito la Cia ha portato un suo contributo con Donato Distefano e Paolo Carbone ed Alfonso Pascale, presidente del Ceslam (Centro Sviluppo Locale in Ambiti Metropolitani).
In questo convegno, con l’individuazione della figura dell’imprenditore agricolo e “custode” del territorio – hanno sottolineano i dirigenti della Cia Distefano e Carbone – c’è la conferma della forte attualità della "Carta di Matera” (che prende il nome dalla Festa Nazionale dell’Agricoltura che la Cia ha tenuto a Matera nel 2012) che continua a rappresentare la “bussola” della nuova strategia dello sviluppo dell’agricoltura e quindi delle aree interne che necessitano di maggiore attenzione. Le nuove sfide dell’agricoltura italiana, la valorizzazione delle aree interne, il sostegno ai giovani agricoltori, il corretto utilizzo dei fondi comunitari: sono questi i temi centrali di quello che abbiamo sintetizzato nella mission ‘il territorio come destino’. La campagna, l'ospitalità rurale, la tradizione contadina – ha detto Carbone – sono parte integrante di Matera Capitale Europea della cultura 2019.C’è tutto l’orgoglio del mondo contadino lucano, che ha saputo conservare e valorizzare i Sassi e che, da sempre, è legato a quel patrimonio artistico-monumentale patrimonio dell’Unesco, per superare il vecchio cliché di mondo rurale simbolo di arretratezza e persino di vergogna. Quattro ani fa – ha ricordato Distefano – la Cia ha voluto qui a Matera la Quinta Festa Nazionale dell’Agricoltura facendola diventare – per quattro giorni – la “capitale dell’agricoltura europea”. Un’intuizione perché – come era scritto – nei deplians distribuiti agli oltre 100mila visitatori “Matera è città patrimonio dell’umanità, da millenni crocevia di culture e tradizioni diverse. Una città accogliente ed ospitale dal fascino irresistibile”. In questa cornice c’è tutto il dibattito sulla multifunzionalità dell’agricoltura che più di recente, si è indirizzato anche sul tema della produzione di beni pubblici in campo sociale destando notevole attenzione, anche a seguito dell’emergere di pratiche innovative e concrete in molti territori dell’Unione Europea.
La gestione di un'impresa agricola ed agroalimentare – ha aggiunto Carbone – necessita, oltre che di conoscenze tecniche e specialistiche, anche di competenze manageriali che supportino lo sviluppo e la competitività. È indispensabile quindi che l'imprenditore agricolo o chi si appresti a diventarlo sviluppi competenze multidisciplinari che lo aiutino a far propri quei criteri di professionalità ed economicità per agire in mercati nazionali ed internazionali sempre più competitivi. Di qui il nostro impegno a fornire le competenze necessarie per una gestione manageriale dell'impresa agricola specie per sostenere la formazione di giovani agricoltori per favorire la crescita professionale di nuovi imprenditori e il ricambio generazionale.
Con la nuova ruralità – ha sottolineato Alfonso Pascale (Ceslam) – sono sorte forme nuove di agricoltura civile e multideale, che vanno dalle pratiche di agricoltura sociale ai servizi per la tutela del paesaggio e la manutenzione del territorio, dalla gestione degli orti condivisi al mantenimento dei “fazzoletti di terra” a fini di autoconsumo personale e familiare, dall’agriturismo alla gestione demani civici. I problemi che pongono queste agricolture si possono così riassumere: abbattere alcune barriere normative; combattere una serie di pregiudizi; chiarire taluni fraintendimenti concettuali. Per quanto riguarda il quadro normativo, manca ancora un chiaro riconoscimento dell’impresa agricola di servizi. I servizi sociali, socio-sanitari, educativi, culturali e ricreativi offerti dalle imprese agricole sono ancora oggi considerate connesse a quelle di coltivazione e allevamento e non già attività agricole a tutti gli effetti. Questa barriera va abbattuta, passando al riconoscimento pieno delle agricolture plurali. L’altro problema da superare –ha continuato Pascale – è il pregiudizio verso l’impresa e il mercato come elementi incompatibili con un’economia etica. Non c’è antinomia tra dono e mercato, tra il gratuito e il doveroso. Per svolgere bene le attività di erogazione di servizi alle comunità e al territorio, è necessario organizzare un’attività economicamente sostenibile rivolta al mercato. Infine, occorre sgombrare il campo da alcuni fraintendimenti concettuali: la multifunzionalità dell’agricoltura non è in antitesi con la competitività; la filiera corta può benissimo convivere con l’internazionalizzazione delle imprese perché la prossimità non si ha solo quando l’esperienza del rapporto produttore/consumatore avviene nel medesimo territorio ma può essere realizzato anche tra comunità lontane che però, attraverso le tecnologie digitali, costruiscono relazioni intime, cioè collaborative; la gran parte dei demani comunali non sono di proprietà dei comuni da sono proprietà delle popolazioni, cioè proprietà collettive, e dovrebbero essere gestite da amministrazioni separate, elette dai cittadini appositamente per organizzare servizi alle popolazioni locali.
Bas 05